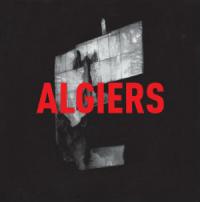E, foss'anche, ti pare poco?
Io sono il primo che fatica a leggere D'Annunzio, lo trovo a volte veramente pesante, però mi pare difficile contestare il fatto che scriva in un italiano meraviglioso.
Assolutamente. Se si vuole imparare come utilizzare la nostra lingua in modo efficace e "sensuale" (nel senso più proprio di muovere i sensi) D'Annunzio costituisce senz'altro una delle migliori scuole. E d'altronde la capacità di amalgamare il linguaggio in modi sensorialmente efficaci è uno dei livelli fondamentali della poesia; ciò che in D'Annunzio mi pare molto scarno sono i due livelli più "profondi", quello metaforico e quello dell'implicito. Le poesie di D'Annunzio sono talmente spostate sul puro contatto coi sensi che i significati, se vi sono, sono quasi impossibili da cogliere.
Francamente trovo decisamente più intrigante, su tutti i livelli, una cosa come questa:
Vecchio stagno...
Tonfo di rana
Suono d'acqua
Che le pagine e pagine di sbrodolate pseudostilistiche in "La pioggia nel pineto". E d'altronde trovo che in Italia abbiamo avuto poeti con una visione d'insieme molto più vasta di quella dannunziana, capaci di tenere assieme sia lo stile "tecnico" sia le significazioni (Montale su tutti, per dire).
E credo che il suo ruolo, come quello del Decadentismo in generale (a cominciare proprio da quel genio di Huysmans) sia troppo spesso bistrattato nelle antologie scolastiche. Ho l'impressione che l'idea della "vita come un'opera d'arte" (che per me resta una delle più belle intuizioni letterarie del periodo) sia vista come qualcosa di moralmente disdicevole, o quantomeno inutile. A differenza del verismo, e di altre correnti letterarie cui vanno tutti gli onori (e oneri per gli studenti) del caso.
Se l'idea è vista in quel modo è proprio perché gli stessi letterati dell'epoca la vivevano così. C'è da ricordarsi che lo stesso Huysmans, che già alla fine di "A rebours" si mostra con Des Esseintes in totale crisi di nervi, dopo quell'estraniante libro sfocierà in una crisi religiosa; oppure lo stesso Don Giovanni kierkegaardiano, rappresentante della "vita estetica", per il suo gironzolare di senso in senso alla fine si ritroverà vuoto e solo; e non ultimo, basso profondo di questa corrente sta l'aforisma di Wilde: "tutta l'arte è perfettamente inutile".
In realtà l'idea non era di una vita come opera d'arte, bensì di una vita estraniata nell'arte, improduttiva, passiva dove poter trovare rifugio dall'aggressività dei tempi moderni e dalla nascente società di massa, vista come estremamente problematica da tutti i pensatori e artisti dell'epoca. Questo proprio perché essi percepivano con chiarezza come il loro ruolo, all'interno di quel nuovo mondo alle porte, sarebbe stato misero e degradato.
D'altronde lo stesso Schopenhauer nella sua opera cardine "Il mondo come volontà e rappresentazione", libro III, mostra un'idea dell'arte già tutta spostata sul piano metafisico, come se anche lui stesse scappando dall'eccessiva operatività del mondo moderno. Questa concezione "idealistica" rimarrà tale anche fino a Croce, per il quale addirittura la vera opera d'arte era solo un'immagine mentale (!!!).
L'idea della
vita come opera d'arte, nel suo senso più completo, è in realtà un ideale molto più vicino alla classicità greco-ellenica, epoca nella quale - come hanno analizzato le splendide opere di Foucault e Hadot - si concepiva proprio una sorta di
estetica dell'esistenza, ovvero una capacità di
plasmare attivamente la propria vita di modo da diventare un'opera d'arte vivente. Questa stessa opera però prevede delle pratiche, delle tecniche, degli esercizi che si operano su se stessi per darsi una forma bella.
La cosa più interessante è che quest'idea è stata alla base di quasi tutta la produzione artistica dell'estremo Oriente dall'antichità in poi: la pittura e la musica cinesi, l'arte del bonsai, l'ikebana, la cerimonia del tè e il teatro No in Giappone - ma in realtà anche molte altre cose, ovvero tutto ciò che è stato ispirato dal buddhismo zen, dal taoismo e dallo shintoismo - sono tutte espressioni artistiche in cui la persona, nel momento in cui partecipa a tali forme espressive, abbisogna di modificare e trasformare se stessa in modo attivo. Cosa assolutamente non distante dall'idea plotiniana della vita bella come un "continuo scolpire se stessi nell'anima per raggiungere la forma perfetta" (guardacaso Plotino aveva frequentato maestri indiani, e la sua filosofia è letteralmente pervasa di concezioni vediche).
Tutto questo è purtroppo molto lontano dall'idea decadentista, dove la negazione della materialità era - soprattutto in area tedesca - una reazione istintiva al drammatico shock dell'immanente crollo di tutti i valori romantici. La differenza è che l'Italia questa sensazione profonda del crollo non l'ha mai avuta, poiché non ha mai avuto grandi ideali monolitici da far crollare. La nostra capacità - pregio o difetto che sia - è sempre stata quella di prendere le cose in modo leggero, di aleggiare in modo scanzonato sulle forme e sulle apparenze piuttosto che invischiarci con le Substanz e i Begriff. L'Italia è stata anche - e per buona parte - il paese di Boccaccio, di D'Annunzio, delle caricature dei Carracci, del trash e della cultura del disimpegno anni '80. I nostri Gadda, Pirandello, Leopardi e Ungaretti erano solo l'altra faccia di questa medaglia di cui - che lo si voglia riconoscere o meno, che lo si accetti o meno - è costituita l'intera cultura italiana. Qualcosa su cui non possiamo semplicemente chiudere gli occhi, ma accettare e comprendere per poterci infine capire meglio.